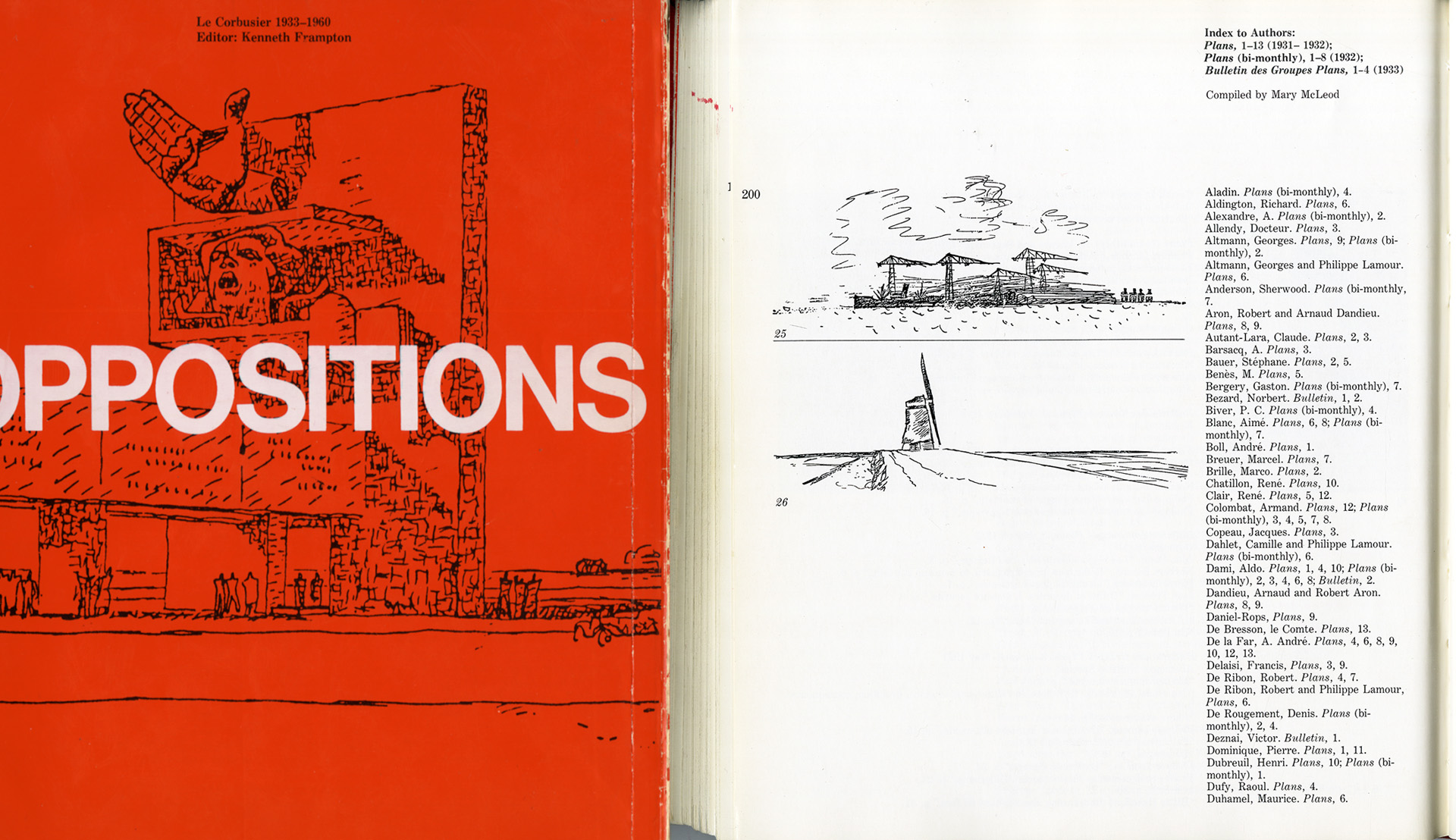Pubblichiamo il dialogo sul tema “Architettura e Italia. Politica e contesto”, realizzato nel 2012 a New York tra Gregorio Carboni Maestri e Jean-Louis Cohen. archphoto ringrazia gli autori per aver gentilmente concesso la pubblicazione del testo.
G.C.M.: Anni fa, tra il 2002 e il 2007, ancora studente, avevo condotto una ricerca inedita, che diventò poi una tesi di laurea, il cui relatore fu Eduardo Souto de Moura, e un libro, di prossima pubblicazione, sull’italofilia nell’architettura portoghese contemporanea. Uno studio originale, su cui non c’era quasi niente prima, sull’influenza che ha avuto Aldo Rossi e la Tendenza, ma più in generale l’architettura italiana, in Portogallo e nella Scuola di Oporto. Una tesi che creò una certa polemica al Politecnico di Milano. Non conoscevo ancora il tuo studio La coupure entre architectes et intellectuels: ou les enseignements de l’italophilie.
J.-L.C.: Conosci Marta Caldeira?
G.C.M.: Sì, ci siamo visti nel 2010, quando stava iniziando il suo dottorato su un tema simile. Fu Peter Eisenman a parlarmi di lei, per la prima volta, dopo aver visto la mia tesi di laurea.
J-L.C.: Perché lei si è concentrata sul Portogallo e…
G.C.M.: … sull’Iberia, più in generale, sulla Spagna e il Portogallo e sull’influenza che ebbero le scuole italiane sulla penisola. Lei rifiuta l’idea di separare i due paesi. Secondo me, invece, sono due realtà molto distinte. E lo sono da oltre mille anni. Quando scrissi quella piccola tesi, scoprì cose interessanti, mai pubblicate, sui rapporti fra Italia e Portogallo, già presenti all’epoca di Ernesto Nathan Rogers. E, poi, via via, passando per Álvaro Siza Vieira e lo stesso Eduardo. Da qui nacque, diciamo, poi, il mio interesse per gli Stati Uniti d’America, cercando di capire l’influenza che ebbero le scuole di Venezia e Milano, ma non solo, a New York. Proprio su questo tema è il bellissimo libro, scritto da Ernesto Ramon Rispoli, Ponti sull’Atlantico. Ha fatto più o meno lo stesso processo: esaminato i rapporti fra Italia e Stati Uniti, attorno all’Institute of Architecture and Urban Studies, la rivista Oppositions, ecc. È un libro molto interessante, fatto molto bene, di storia, frutto della tesi presso il dottorato in Storia e Progetto del Politecnico di Torino…
J-L.C.: Sì, è stato pubblicato da Manuel Orazi, dalla Quodlibet di Macerata…
G.C.M.: Ci siamo scambiati molte idee a riguardo, è un ricercatore molto bravo. Nel libro Ponti sull’Atlantico, il tuo studio viene citato. È scritto molto bene. Nella mia tesi di dottorato, mi sono concentrato soprattutto, su altri aspetti che m’interessano molto di più: cos’è successo negli anni Settanta negli USA? […] E ancora più in generale, quale è rapporto fra architettura e ideologia, nelle decadi dei ’60 e ’70 del Novecento?
J-L.C.: Sì, Infatti, non puoi incominciare negli anni Settanta…
G.C.M.: No, chiaro. Infatti, la cosa problematica è che sto andando sempre più indietro. È così che si fanno le cose, ed è così che si fanno le cose nel materialismo storico [risate] Infatti, alcune delle mie domande riguarderanno gli anni precedenti ai Seventies. A me interessa molto il rapporto con l’ideologia, con la questione dei movimenti sociali. In modo, diciamo, strutturale. È una cosa che altri studiosi non esplorano secondo me abbastanza. E che a me interessa molto da architetto, cioè anche dal punto di vista della questione formale. Cosa è successo a livello architettonico negli anni 1970? Perché si arriva alla post-modernità? Insomma… Ecco, questo è un po’ il punto. E dunque sto usando l’IAUS e Oppositions un come un case study, perché secondo me incrociano molti aspetti interessanti. Ma sto cercando qua, come ho fatto in Portogallo, di capire cos’è successo attorno alla figura di Tafuri, alle questioni che lui ha posto, Rossi ecc. Ma, prima inizierò dal chiederti qual è stato il tuo percorso. Cioè, come hai incrociato l’Italia?
J-L.C.: È semplicissimo: io ho iniziato a studiare architettura nel 1967 a Parigi, non all’École des Beaux-Arts, che mi spaventava un pochino, poiché era un universo apparentemente caotico, e anche abbastanza reazionario. Anche se in realtà non sapevo che c’erano dei luoghi —degli ateliers— più sperimentali. Quindi sono andato all’École spéciale d’architecture, una scuola privata, creata come attrattiva moderna da Viollet-le-Duc e poi in parte degenerata. Ero abbastanza centrato su quello che era il mio principale interesse: il lavoro di Jean Prouvé, le conferenze che faceva a Parigi, l’America in maniera generale. Leggevo molti libri e riviste. Poi nel 1969 sono andato in una delle scuole create dopo la chiusura della sezione di architettura dell’École des Beaux-Arts, chiamata UP6, che era la più grande, e anche forse la più sperimentale. Lì ho finito di studiare. Mi sono laureato nel 1973, che è una data già abbastanza storica. Una tesi ldi aurea che è stata peraltro interessante. Il titolo era un po’ naif, se ci penso retrospettivamente: Y-a-t’il une pratique architecturale de la classe ouvrière? Non so chi tra i Veneziani l’avesse scoperta, ma sta di fatto che vi fecero una recensione a riguardo su Casabella. E fu così che incontrai Tafuri, del quale avevo già letto alcuni saggi iniziali, e Progetto e Utopia, forse una settimana dopo la sua pubblicazione. Ero allora molto attivo nel Partito comunista francese, in una specie di faccia eurocomunista e quindi interessatissimo all’Italia. In Italia vi era un’apertura che non c’era nel contesto francese. Da un lato, leggevo Gramsci o materiale di politica italiana, dall’altro lato, leggevo Tafuri, ma anche Bruno Zevi, che era stato tradotto in francese già negli anni 60. È interessante notare che — e questo forse dovrei scriverlo nella premessa alla nuova edizione de l’Italophilie —, il mio primo articolo sull’architettura contemporanea è stata una recensione della Triennale del 1973, — la Triennale di Aldo Rossi —, per la rivista degli intellettuali del PC francese: La Nouvelle Critique. Puntavo a raccontare realmente di tutto questo ambiente milanese.
G.C.M.: E com’era studiare architettura negli anni cerniera del movimento di classe europeo. Cioè, dal 1968 agli ultimi anni del 1970? In che modo l’arte del costruire assorbiva questo fervore politico. Se lo assorbiva?
J-L.C.: Sì, sì, l’assorbiva molto. Era un momento nel quale si faceva più politica che non progetti. C’era anche un intreccio tra politica e teoria, perché a Parigi potevi assai facilmente ascoltare i seminari di Louis Althusser, Michel Foucault e tutti gli altri intellettuali di rilievo. Quindi il livello di politicizzazione nell’insegnamento era fortissimo.
G.C.M.: E tutto questo contesto, come ha cambiato le forme dell’architettura?
J-L.C.: Inizialmente non è cambiato molto. Perché non c’è stata una condizione progettuale abbastanza forte. Per quanto riguarda gli studenti e giovani docenti delle generazioni della fine degli anni Settanta, non vedo in retrospettiva una relazione diretta. Alcuni progetti sono nati con un populismo alla Giancarlo De Carlo: l’idea della relazione con l’utente, al quale un certo potere sulla forma poteva essere delegato. Però, in generale, con una forma abbastanza debole. Altri hanno prodotto forme più forti. Però non li vedo molto come risultato del ’68.
G.C.M.: In toile de fond, diciamo c’era un rapporto critico nei confronti del Movimento Moderno e dello Stile internazionale?
J-L.C.: In Francia non c’era un discorso molto critico rispetto alla storia. Devo dire che non eravamo in molti ad interessarci alla storia perché il bersaglio di tutte le critiche era la professione e la sua struttura di potere, mentre c’era anche una specie di religione morbida di Le Corbusier. L’orizzonte più stimolante era quello di Louis Kahn o Charles Moore, dal lato statunitense, e un interesse per Gaudí che sembrava un’alternativa liberata sia ai Beaux-Arts che a Le Corbusier. Era un sistema abbastanza complesso nel quale io m’interessavo ad altre cose. È anche così che sono arrivato a fare storia. Il discorso che si era sviluppato sull’avanguardia russa attraverso il libro di Anatole Kopp, pubblicato nel ’67, Ville et révolution, è stato determinante. Attraverso Kopp, che conoscevo e con il quale ho lavorato alcuni mesi, ho iniziato ad andare in Unione Sovietica già da studente, a partire dal 1971, per vedere gli edifici dell’avanguardia. E poi ci son andato in maniera sistematica dal ’73 in poi. Quindi mi son messo a fare storia per prima sull’avanguardia russa, prima di spostarmi sul lato italiano. Questo è arrivato più tardi, dopo la Biennale di Venezia del 1976. Io allora avevo scritto questo articoletto sulla Triennale del 1973 e m’interessavo sempre di più all’Italia. Attorno al 1976-77, ho portato a Parigi la mostra sull’architettura durante il fascismo curata da Silvia Danesi e Luciano Patetta alla Biennale del 1976 e ne ho tradotto e redatto il catalogo.
G.C.M.: Avevi mantenuto il rapporto con Manfredo Tafuri dopo il tuo primo incontro del 1973?
J-L.C.: Siamo diventati molto amici. Io non ho mai insegnato per un lungo periodo a Venezia, ma sono stato molto spesso a fare delle conferenze, rimanendo legato anche a progetti interessanti sviluppati in maniera triangolare tra il dipartimento di storia dello IUAV, la scuola di Belleville a Parigi e la Hochschule für bildende Künste di Hartmut Frank ad Amburgo. Nel 1973 Tafuri era interessato a parlarmi perché sapeva che sarei andato in Russia. Più o meno allo stesso momento avevo incrociato Francesco Dal Co e Marco De Michelis e quindi quelli a me più vicini in termini generazionali. Poi, allo stesso tempo, anche Rem Koolhaas mi contattò perché lui lavorava allora sull’Unione Sovietica, sviluppando la sua ricerca su Ivan Leonidov.
G.C.M.: Perché, in quegli anni, era all’IAUS, e cosa abbastanza nuova ed insolita per il contesto statunitense, stava studiando molto l’architettura sovietica.
J-L.C.: Era una novità assoluta. Però è Kenneth Frampton ad aver portato il discorso sull’architettura dell’URSS, non è l’Institute. E, oltre a Frampton e Koolhaas, si è tutto fermato lì.
G.C.M.: Quando ero più giovane e più progettista che ricercatore, avevo una pseudo-teoria che ho poi decostruito in parte. Una delle domande che mi attanagliavano da molti anni, e nello specifico l’architettura sovietica, è che osservavi come, nei momenti in cui vi sono processi rivoluzionari, prerivoluzionari o di forti movimenti di classe, vi sia un processo di semplificazione formale in architettura. Un fenomeno osservabile nelle avanguardie dei grandi momenti di modificazione storica o di cambio politico. Un po’ quello che nel tuo libro sull’Italofilia chiami di sette, no? Quello che è riscontrabile per certo, è il processo di idealizzazione, e dunque di necessaria chiarificazione formale di idee nuove. La semplificazione formale, o meglio, la rielaborazione formale, è dunque quasi processo di propaganda, di esplicitazione del nuovo ordine teorico.
J-L. C.: Sì, forse hai ragione, perché l’architettura diventa mass medium. Era la tesi di Adolf Max Vogt, nel suo libro intitolato Russische und französische Revolutions- Architektur 1917/1789, pubblicato in tedesco nel 1974. Vogt insegnava a Zurigo e faceva un paragone tra le architetture cosiddette rivoluzionarie – francesi e sovietiche. Più concretamente, tra Claude-Nicolas Ledoux, Etienne Louis Boullée e Leonidov.
G.C.M.: Ecco. Infatti, per un tale ragionamento bisogna partire dai francesi, dalla Rivoluzione…
J-L.C.: Era un momento nel quale non si costruiva, nel quale si faceva un’architettura esasperata, un’architettura di carta.
G.C.M.: Esatto! Che è un po’ quello che successe nell’Italia degli anni di Rossi. E per una serie di motivi politici, si era ripreso con interesse lo studio dell’idealità della fase prerivoluzionaria e rivoluzionaria francese. Architetti come Canella, poi, hanno ripreso la tradizione di quella russo-sovietica. E vi era anche un rifiuto, in un certo senso, del costruire, del compromettersi con l’economia di mercato, con la speculazione edilizia. Il non costruire era quasi un atto voluto, legato alla tensione teorica di quell’architettura. Un’architettura di carta, “manifesto”. E, in minor misura, è ciò che accadeva in molti contesti architettonici negli anni 1960 e soprattutto 1970. Nel caso statunitense vi era la crisi economica. E in quel contesto Peter Eisenman portava molto dello zeitgeist italiano nel contesto statunitense, epurato, però, di qualsiasi contenuto marxista, di lotta politica.
J-L.C.: Non possiamo dire che Eisenman abbia proprio studiato la forma con la stessa prospettiva.
G.C.M.: No. Ma possiamo dirlo dei costruttivisti sovietici?
J-L.C.: Si, se vedi Leonidov, sì. C’era una tendenza ad una certa astrazione platonica.
G.C.M.: E non pensi che, a modo suo, all’americana, e in un contesto non certo di tensione comunista, ma certamente di tensione politica, anche Eisenman e il suo gruppo, abbiano lavorato sull’astrazione?
J-L.C.: Sì, però c’è una tale esasperazione delle reti formali, che è un po’ difficile dirlo.
G.C.M.: Io un po’ la intravedo questa tensione teorica…
J-L.C.: In contrasto al New Shingle Style, si è ritornato a una specie di cubismo, bianco, anche molto travagliato.
G.C.M.: Nei New York Five e nel New Shingle Style, se non è la questione della semplificazione formale che è in gioco, possiamo dire che si tratti, comunque, di un cambio di paradigma formale. Che avviene nel contesto di una tensione, di tentativo di cambio politico di una parte del proletariato statunitense, no? Fare un paragone con la Francia del 1789, della Russia del 1917 o dell’Italia del post 1945, e nello specifico del 1963-77 italiano, sarebbe molto azzardato, e necessita di molti distinguo, ma…
J-L.C.: C’è forse qualche verità qua. Il problema è poi di capire che cosa è capitato. In altri termini: perché c’è una sovrapposizione della situazione di cambio e di rottura politica, di critica sociale e anche delle istituzioni didattiche? Il ‘68 è stato una crisi sociale complessiva. Anche una crisi delle scuole, dell’università in generale, delle scuole di architettura in particolare. Anche la Rivoluzione russa a indotto il crollo di un certo tipo di prassi didattica. Però in questi casi c’è una coincidenza. Nel caso americano, forse sotto la pressione demografica degli anni ‘60, del movimento contro la guerra del Vietnam e dei diritti civili, la dimensione arretrata delle scuole diventa più palese. Quindi sì, sono dei sistemi abbastanza paragonabili.
G.C.M.: Alla presentazione del film The Making Of An Avant-Garde: The Institute For Architecture And Urban Studies 1967-1984, prodotto e realizzato da Diana Agrest, parlavi di come, giovane studente, aspettavi sempre con ansia l’arrivo dei nuovi numeri della rivista Oppositions. Puoi parlarmi un po’ di cos’era Oppositions, di cos’era l’Institute, all’epoca, per voi, per gli studenti della tua generazione?
J-L.C.: Nel contesto francese, la storia non era molto eccitante. Anche Anatole Kopp, che amavo molto, mi sembrava fare un discorso assai semplificato sul rapporto tra architettura e politica. Come antidoto, ho letto il libro di Manfredo Tafuri ed altri sul contributo degli architetti europei all’architettura russa. Con Tafuri ho scoperto un discorso di una complessità, di una dialettica molto più stimolante. Ed era un po’ quello che ho poi scoperto leggendo i primi numeri di Oppositions. Leggevo molto anche Architectural Design, e ovviamente Casabella, che all’epoca era quella di Mendini. Ero nel milieu culturale parigino già accennato, nel quale avevo una curiosità che non trovava un riscontro nel discours francese. Oppositions rappresentava invece un’America più critica, non corporate. Quindi m’interessava perché conteneva un discorso totalmente diverso, anche se con alcuni momenti contraddittori.
G.C.M.: Dopo la presentazione del film, durante il dibattito, e dopo il mio intervento, hai detto una cosa molto interessante, e secondo me molto importante, su Gramsci, sull’interpretazione gramsciana di ciò che sono gli intellettuali. È molto interessante questo aspetto : cioè, Oppositions in realtà qua negli Stati Uniti d’America era vista come una piccola rivista di tendenza, con una diffusione limitata a poche copie se comparata con altri grandi magazines. Però, in realtà, rappresentava la figura, nuova, dell’architetto intellettuale progressista, nella sua versione statunitense, cioè in cui liberal democrazia si mescola ad accenti di proto-marxismo e radicalismo empirista. Rivista che, non di meno, ha avuto forse l’impatto più forte tra le riviste dell’epoca sul contesto architettonico.
J-L.C.: L’architettura —e non voglio parlare di essenze astratte— ha sempre una capacità a cristallizzare il momento sociale, il momento culturale, a dargli una forma. E quindi è vero che Oppositions e l’Institute erano luoghi che avevano una radiazione che andava addirittura oltre gli architetti. Io ero molto allora affascinato dall’America. Avrei voluto studiare qua, forse con Kahn. Ma, siccome ero molto attivo nel Partito comunista, non potevo ricevere un visto. L’ho potuto avere solo molto più tardi. Soffocavo all’idea di non poter conoscere di persona il contesto americano. E questa rivista era un’apertura interessante in tal senso. Però non ero sempre completamente d’accordo con quello che vi scrivevano…
G.C.M.: Cioè?
J-L.C.: Dovrei rivedere la mia collezione per dirti quali sono gli articoli che ritengo importanti…
G.C.M.: Se avessi tempo di farlo un giorno sarebbe bellissima questa operazione. Magari lo facciamo un giorno.
J-L.C.: Devo anche dire che ho iniziato ad insegnare appena dopo essermi laureato nel ‘73. A partire dallo stesso anno, ho anche incominciato ad andare ogni anno, due o tre volte all’anno, in URSS, e a incontrare tutti i veterani dell’avanguardia storica, a parlare con loro. Mi sono messo a scrivere e insegnare su questi argomenti dal ‘75 in poi. Una delle mie reazioni insegnando storia del Moderno, in una scuola parigina, era di dire che, a un certo punto, non si capiva niente parlando solo del Moderno. Non dico che dobbiamo insegnare una storia enciclopedica come quella che si faceva alle Belle Arti, dalla Mesopotamia al Moderno, però… Ho creato un corso sul Rinascimento, forse anche col modello inconscio di Tafuri che aveva lavorato da un lato su Sansovino e dall’altro su Quaroni.
G.C.M.: Visto che parli di Movimento Moderno, possiamo toccare ora questo argomento. Ho una diatriba molto accesa con Peter Eisenman sulle cose delle quali stiamo parlando ora. Vi sono temi sui quali non riusciamo ad essere d’accordo. Peter insiste perché io cambi direzione nelle mie ricerche, che sostiene essere troppo marxiane. Soprattutto, dice che l’Institute e Oppositions, di ideologico e di politico non avessero niente. Tecnicamente è vero, nel senso che non erano ufficialmente di sinistra. Però neanche il contrario è completamente vero. Perché, in realtà, esprimevano, diciamo, un corpo intellettuale più progressista, mi azzarderei a dire uno dei più progressisti nel contesto architettonico statunitense. L’intellettuale può anche non essere ufficialmente di sinistra —e credo che molti dei componenti dello IAUS non lo fossero ufficialmente— ma intercettare, allo stesso tempo, la tensione del momento storico. Eisenman sostiene che i teorici marxisti erano soprattutto in Italia…
J-L.C.: Magari l’Institute non era di sinistra, ma era indubbiamente critico, anche se non corrispondeva a definizioni politiche precise. Non dimentichiamo il ruolo di Frampton, perché era un po’ l’ala più di sinistra ed europea, rappresentava un altro discorso all’interno dell’IAUS.
G.C.M.: Esatto. Peter Eisenman sostiene, come sai, che negli USA non vi sia stata un’avanguardia, e, sibillinamente, che, in fondo, sia stato lui a creare la prima avanguardia, tramite l’IAUS…
J-L.C.: Conosco bene questa mitologia, che è storicamente falsa.
G.C.M.: Ed è vero che, in un certo qual modo, gli Stati Uniti non abbiano avuto un’avanguardia, con gli stessi canoni, con la stessa potenza, con la stessa forza dell’Europa, o anche di altri contesti non europei…
J-L.C.: Sì, io penso la stessa cosa. Un’avanguardia è esistita, è stata strangolata da istituzioni come il MoMA, per esempio. Ciò che vorrei aggiungere, però, è che il discorso di Peter, per quanto sia una totale ricostruzione, non è solo di responsabilità sua. Il discorso storico sull’architettura americana è stato totalmente codificato e costruito, come quello scritto sotto l’egemonia di Gropius in Germania, o come quello scritto in Francia sotto il controllo degli storici dell’arte più superficiali o di agenti degli architetti, come Michel Ragon. Quindi non è totalmente colpa sua, anche perché aveva una specie d’idealizzazione della vicenda parigina, in particolare di Le Corbusier, non capendo totalmente ciò che rappresentava veramente.
G.C.M.: Certo. Però quello che trovo interessante, che sto studiando molto, anche con Frampton alla Columbia, è come l’avanguardia europea, quella tedesca, quella francese, in modi diversi, abbia intercettato, a partire soprattutto dagli anni venti, i fortissimi cambi dovuti alla pressione sociale. Cioè, l’Europa era in fasi prerivoluzionarie. In Germania gli Spartachisti, il rapporto, per quanto contraddittorio, tra Bauhaus e socialismo, nel paese dal più grande partito operaio d’Europa. In Italia vi era il Biennio rosso, e così via. In questi e in quasi tutti i contesti europei e sudamericani, è chiaro come l’architettura e il movimento moderno abbia intercettato queste innumerevoli volontà di cambio rivoluzionario, siano essi stati sociali, di sinistra o spirituali. Ma Peter, e altri, mi rispondono “no, questa è una cazzata, perché Le Corbusier era fascista”. Invece non è così semplice, perché Le Corbusier era quello che era, ma anche il Fascismo, per quanto sotto forma retrograda, reazionaria, antioperaia, anti-comunista, miogena e nazionalista, rispondeva —sotto queste forme— a una più generale volontà di cambio rivoluzionario…
J-L.C.: …. C’è una visione totalmente rozza del rapporto di Le Corbusier con la politica. Nel caso di Corbu e di molti altri episodi del Movimento moderno, vi è il discorso della modernizzazione sociale. E Le Corbusier é cambiato negli anni. Il Corbusier del 1928 è abbastanza schierato dal lato degli industriali, quello del 1936 è più sotto la pressione dei giovani dello studio, molto più legato al Fronte popolare francese, quindi molto più rivoluzionario…
G.C.M.: Certo. Poi, comunque, qualunque cosa abbia pensato o detto Le Corbusier, alla fine, il primo titolo del suo libro fu Architecture ou Révolution, che è abbastanza chiaro… Certo, era una rivoluzione diversa, nella sua testa, da quella che sognava la classe operaia anticapitalista…
J-L.C.: Anzi! Quando lo scrisse nel ‘23 s’identifica molto con i padroni, perché aveva fatto da piccolo imprenditore durante la guerra, per poi fallire. Era ancora pieno di rabbia contro i socialisti di La Chaux-de-Fonds. C’è tutto un contesto preciso legato all’esperienza della guerra, che durò fino all’inizio degli anni trenta. Poi c’è anche una fase più cinica, nella quale si lascia prendere dalla retorica staliniana, dalla retorica sulla rivoluzione, per poi seguire quella di Mussolini… però il momento cerniera è quello della fine degli anni trenta, quando, sotto la pressione di Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand, agisce a favore della Spagna repubblicana e antifascista.
G.C.M.: Poi, c’è l’amore di Peter per Terragni, che era, invece, un mussoliniano dichiarato e convinto… come la mettiamo?
J-L.C.: Sì ma, come si sa bene, Terragni aderiva a ciò che ha significato il fascismo per la gioventù di quell’epoca, ai suoi apparenti aspetti di modernizzazione sociale. Non possiamo dire di Terragni che fosse dal lato brutale del fascismo. Era, come molti architetti, legato al lato utopico, corporativistico. Erano questioni molto diverse. Tutte queste cose che Peter Eisenman dice, si basano spesso su una visione molto impressionista, fatta di slogan…
G.C.M.: Già all’epoca di Oppositions, Eisenman cerca sempre questa tensione problematicizzata con la questione ideologica, con la questione politica.
J-L.C.: La cosa fondamentale per me è questo discorso di Peter sull’autoreferenzialità dell’architettura, che va aldilà del concetto dell’autonomia.
G.C.M.: Esatto. C’è un’altra questione problematica che si pone all’epoca di Tafuri. Questo grande ribollimento che c’è nell’architettura italiana – le scuole di Venezia e Milano —, formalmente, pongono la questione l’autonomia dell’architettura, confrontata a…
J-L.C.: … Sì però, caro Gregorio, con un livello di sofisticazione sconosciuto nel resto del mondo! Quando Tafuri parlava di Viktor Shklovsky e del rapporto tra l’arte e il colore nella bandiera sopra la torre, c’era un livello di conoscenza storica e letteraria che non si incontrava da nessun’altra parte. Anche la lettura fatta della scuola di Francoforte in Italia, allora, dove tutti i testi erano già tradotti, non aveva eguali. Poi c’è stata una congiuntura italiana assai più complessa, nella quale questi temi sono stati pensati con un livello di raffinatezza che verrà raggiunta poi solo negli anni ’90 altrove.
G.C.M.: E qua comunque il tema dell’autonomia venne presa—diciamo, e banalizzo volontariamente– totalmente vuotata dal suo contenuto ideologico.
J-L. C.: Sì. Devo aggiungere qualcosa per quanto riguarda quello che dicevo prima sul mio rapporto con l’Italia. E questo mi fa pensare che dovrò aggiungere alcune note autobiografiche alla premessa della nuova edizione di La coupure entre architectes et intellectuels. Leggevo molto la rivista Controspazio, una pubblicazione molto importante per me. Perché proponeva di rivisitare il Futurismo o per esempio di rivisitare il lavoro di Mario Ridolfi. Ho scoperto molte cose sull’Italia leggendo Controspazio.
G.C.M.: La mia idea è che, in fondo, qui, nel Nord America, non vi sia stata una così forte e acuta avanguardia moderna, e poi una Tendenza, come nel caso italiano che citi, anche per via della debolezza e compromissione del movimento operaio statunitense.
J-L.C.: Sì, questo è chiaro, non c’era… Possiamo pensare in un’altra maniera se riflettiamo al rapporto dell’intellettuale americano con la politica. Questa è ancora una questione che vale oggi. In Italia, anche in Germania, in Francia, forse in minor misura in Spagna, un professore universitario politicizzato, può essere candidato alle elezioni locali, diventare parlamentare. C’è una porosità tra il mondo della cultura, quello intellettuale e quello politico. Tutto ciò non esiste negli Stati Uniti, è inimmaginabile di vedere un Cacciari sindaco di Venezia o di vedere il presidente dell’università di Strasburgo, per fare un esempio vicino, diventare vicesindaco alla cultura e fare politica culturale nell’istituzione. Questo non esiste negli USA. Gli universitari sono spinti a una specie di radicalità, quella del politically correct che è proporzionale al distacco rispetto alla prassi politica reale. Questo è la mia molto elementare tesi. E quindi, non è tanto la debolezza della sinistra sindacale operaia il problema, quanto quella della struttura politica.
G.C.M.: In questo momento, negli Stati Uniti, e non solo, vi è un ritorno a una certa italofilia strisciante e non del tutto dichiarata. Il nuovo grande eroe degli studenti anti-decostruttivismo e anti-parametrico è Pier Vittorio Aureli. San Rocco è diventata la rivista alla moda. Anche Tafuri, un tempo dimenticato, è adesso sulla bocca di tutti. È molto chic adesso, per uno studente delle Ivy League o della Architectural Association, leggere Tafuri, e parlarne a lezione… ancora una volta, in una versione non comunistica e politicamente corretta di Tafuri. Però, diciamo che il fantasma che si aggira da alcuni anni, nelle facoltà, tra i giovani, nelle lezioni, dalla Columbia a Yale, è un certo radicalismo postcapitalista e post-Occupy. E, ancora una volta, ad un’ideologia si aggregano nuovi tipi di forme. Non posso esimermi dal ricordare costantemente gli schizzi segreti che faceva Jean-Jacques Lequeu, in cui da una parte metteva i principi fondanti, ideali, teorici, progettuali di una rivoluzione —non ancora avvenuta— e dall’altra, vi associava forme simboliche. E se facciamo un salto temporale, e passiamo, che so, alla prima arte sovietica, poi ad Aldo Rossi, ai suoi riferimenti all’architettura del Realismo sovietico, e ripeschiamo la Triennale di Milano del 1973… torniamo sempre a questioni di semplificazione e comunicabilità e trasmissibilità formale…
J-L.C.: Queste sono idee molto importanti. L’idea della leggibilità dell’architettura è stata già negli anni Trenta una delle legittimazioni del realismo socialista. Il “diritto del popolo alle colonne”, perché rappresentava, finalmente, la possibilità di avere una monumentalità capibile, che poteva essere consumata, in una qualche maniera, dalla popolazione.
GCM.: Ho scoperto negli archivi del Centro canadese d’architettura che la collana Oppositions Books aveva in progetto di pubblicare uno dei tuoi libri: Avant-garde et formalisme entre la NEP et le premier plan quinquenal, che avevi scritto con Tafuri e De Michelis.
J-L.C.: Era un libro che avevo inventato dopo una mostra del 1978 al centro Pompidou, e che poi è stato pubblicato solo in francese e in italiano. Interessantissimo, non lo sapevo neanche!
G.C.M.: Forse l’idea era di Tafuri, che era in contatto con l’IAUS in quegli anni. Non lo so.
J-L.C.: Sì, e io incominciavo ad avere relazioni con loro tramite Frampton che avevo incontrato a Londra, e che conoscevo bene. Avevo conosciuto poi anche Mary Mc Leod. È tramite Kenneth che pubblicai il mio articolo su Le Corbusier in Oppositions. Peter [Eisenman] l’ho poi incontrato solo nel 1981.
G.C.M.: E cosa ti ricordi di questo incontro?
J-L.C.: Ci siamo incrociati così, all’Institute, e abbiamo pranzato alla Century Association, allora ancora chiuse alle donne. Soprattutto abbiamo parlato —perché questa è una passione di Peter— della Seconda Guerra mondiale. Io gli ho raccontato vicende di mia madre, che era stata deportata nel campo di Auschwitz e poi siamo rimasti in contatto.
G.C.M.: Sto finendo di leggere La coupure entre architectes et intellectuels, che è interessantissimo. Come ti dicevo all’inizio di questa chiacchierata, mi sembra che vi siano moltissimi paralleli del tuo studio con il Portogallo e con gli Stati Uniti, di cui abbiamo parlato qui, per quanto concerne l’italofilia e il legame tra architettura e politica. Durante gli anni del fascismo di Salazar, gli architetti vedevano l’Italia mussoliniana come un’alternativa alle politiche architettoniche lusitane. Salazar imponeva il Português Suave, uno stile tardo-Novecento abbastanza noioso, per dirla tutta. Dopo la Rivoluzione, di nuovo, l’Italia ha costituito un modello, questa volta proprio per la sua capacità a legar continuità, storia, intellettualismo, militanza, politica e centralità della città. È questa figura dell’intellettuale organico, che ha affascinato il mondo, e che ora si perde, con la Fine della Storia, no?
J-L.C.: Certamente. L’architetto italiano era intellettuale in una maniera totalmente diversa da quello che si vede nella situazione francese e americana. Gli architetti erano vicini al mondo intellettuale, e al mondo della politica.
G.C.M.: Grazie per questa bellissima chiacchierata!
J-L.C.: Grazie a te per il tuo ascolto!
Jean-Louis Cohen è titolare della cattedra Sheldon H. Solow in storia dell’architettura presso l’NYU.
Gregorio Carboni Maestri, PhD, architetto, Maître de conférences invité (UcLouvain) e Maître enseignant en projet d’architecture (ULB) – Bruxelles.
Immagine di copertina: Oppositions 19-20, editor Kenneth Frampton, 1980.