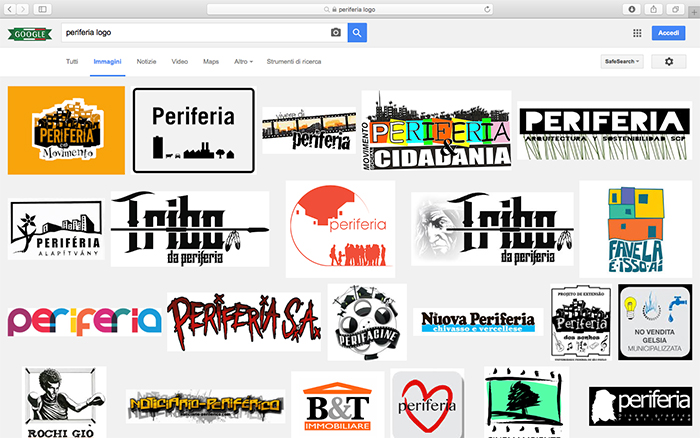Luigi Manzione. Periferia: una parola da riqualificare, non da dismettere
|
L’ultimo numero della rivista Limes (4/2016) è dedicato ad una “indagine sulle periferie”, con la messa a fuoco progressiva delle situazioni italiana, francese e mondiale in una prospettiva geopolitica con diramazioni pluridisciplinari. Nell’editoriale si sottolinea il carattere passe-partout del termine “periferia” di cui “sono state censite almeno duecento diverse, talvolta contraddittorie accezioni”.(1) Per descrivere il passaggio da una crescita urbana millenaria (sul modello della geometria euclidea) all’attuale (più prossima alla geometria frattale) è in via di costituzione, da più di un trentennio, un vocabolario di spessore e interesse variabili. Città diffusa, non-città, edge city, excity, métapolis, ville éclatée sono alcune delle espressioni di nuovo conio per una realtà largamente inedita e sfuggente, verso la quale si reagisce ancora con stupore e con un senso di inadeguatezza teorica e progettuale. La condizione aleatoria e proliferante, la diversità di modi, spazi e forme dell’habitat attuale hanno finanche indotto a proporre di bandire l’uso del termine “periferia”, in quanto parola che non avrebbe più alcun significato plausibile.(2) Sulla perdita di senso non si può che concordare. A partire dal fatto, non certo recente, che la periferia non riproduce più, come nel suo significato etimologico, alcuna circonferenza da oltrepassare; non coincide più con l’espansione della città a corona, per satelliti, a macchia d’olio o secondo altre figure riconoscibili; non riesce più a parlarci delle mitologie e delle speranze di riscatto (affidate in Italia alla Ricostruzione e proprio da questa, o dai suoi esiti tardivi, in buona parte tradite). È inoltre innegabile che la parola periferia sia diventata un improbabile grimaldello, che dice tutto e niente, le cui numerose e discordi accezioni sono spesso prive di connessioni con la realtà. In quanto tale, e forse proprio per questo, la parola è stata adottata nella sua smisurata estensione dal linguaggio politico, per alimentare risse da talk show, discorsi e programmi elettorali, puntualmente gettati nel cestino ad urne chiuse. O, il che è peggio, dati in pasto ad una burocrazia non di rado ottusa e incapace. Se non si può non essere d’accordo sulla deriva semantica della parola, si rimane invece perplessi di fronte all’idea di eliminarla dal vocabolario (fosse anche solo da quello disciplinare). Interdirne l’uso sarebbe infatti come dismettere una cosa che non funziona più come prima, anche se sappiamo che ci sarà ancora utile, almeno finché non potremmo averne una nuova. Così si consegnano un concetto e una realtà sempre più complessi e problematici nella mani di chi ne fa un uso semplicistico e prevalentemente strumentale e propagandistico. Riducendo quel concetto a puro slogan e quella realtà a pretesto demiurgico (sia che la si tema per ragioni securitarie, sia che si intenda intervenirvi per trasformarla e “regolarla”). Di fronte alla perdita di senso del termine si può però reagire altrimenti. Riconosciute le difficoltà di conferirgli un significato attuale, ci si potrebbe rimettere ad osservare i territori periferici, senza dogmatismi e preconcetti, con la consapevolezza di ripartire quasi da zero, rivolgendo lo sguardo anche agli apporti delle scienze umane e sociali, dell’arte contemporanea, della fotografia, del cinema, della letteratura. Ricostruire quindi un oggetto di studio, senza pretese di assoluta scientificità ma con rigore, parlando di cose concrete con un linguaggio comprensibile, con metodi e strumenti aggiornati e verificabili, in vista di obiettivi quanto più possibile condivisi. Nella triplice metafora – conoscenza, memoria, linguaggio – che investe pure la periferia in quanto altra specie di città, quelli di suburbia sono territori “caldi” (nel senso attribuito da Claude Lévi-Strauss alle società). Territori in trasformazione e abbandono continui. Spazi inerti o iperattivi, amnesici o reminiscenti in perenne attesa. “Queste amnesie urbane non sono solo in attesa di essere riempite di cose, ma sono spazi vivi da riempire di significati. Non si tratta dunque di una non-città da trasformare in città, ma di una città parallela con dinamiche e strutture proprie che devono essere comprese.”(3) Quindi ripercorse, rinominate… Del resto, continuiamo ad usare la parola “città”, eppure il suo significato è profondamente cambiato nell’ultimo secolo. Dovremmo per questo espungerla dal dizionario? Il problema che si pone in relazione alla indeterminatezza del termine “periferia” non è dissimile da quello con cui si confrontarono architetti, urbanisti e geografi nel periodo tra le due guerre del Novecento. Allora la parola criticata era appunto “città”. Di fronte a trasformazioni radicali, al diffondersi di processi inediti di urbanizzazione e di forme di insediamento, figure come Erwin Gutkind, Rudolf Schwarz, Luigi Piccinato, Gaston Bardet, Melvin Webber (e prima di loro Patrick Geddes) si interrogarono su cosa fosse diventata la città. Sui processi e gli scenari di una città che si proiettava già ben oltre gli antichi confini per raggiungere e oltrepassare – in una dissoluzione inarrestabile – le periferie e le regioni urbane. Ritornando appunto a percorrerla e a nominarla, alcuni di loro proposero parole nuove: Bardet introdusse ad esempio l’espressione “taches agglomérées” (macchie agglomerate) per indicare nuovi tipi di insediamenti dispersi sul territorio.(4) Gutkind scrisse perfino un libro apocalittico, ma non altrettanto profetico almeno in quella forma – The Twilight of Cities – in cui la riformulazione del tema città si sposta dal campo del lessico a quello del principio (dispersione versus rinnovamento) e del concetto che, secondo Gutkind, diviene un anacronismo per il quale “nessuna riforma, seppure di grande respiro, potrà impedirne la disintegrazione e la scomparsa.”(5) Tuttavia continuiamo a chiamare città questi organismi che si trasformano, attraversano periodi di crisi e di rinascita, si confrontano e si oppongono con le periferie. E finora non è stata ancora trovata un’espressione più aderente, o solo più evocativa e meno problematica, della parola “città”. Pur con la sua approssimazione, e nonostante i tentativi ciclici di introdurre nuove definizioni, questa parola mantiene dunque saldo il suo posto nel dizionario. Privarsi invece dell’uso del termine “periferia” quali vantaggi comporterebbe, ammesso che si riesca a coniarne di nuovi e più precisi? Metterci sopra un tratto di penna non servirebbe piuttosto a favorire chi se ne appropria senza alcuna conoscenza e competenza? Chi si avvale della sua ambiguità semantica per piccoli e grandi giochi di potere? E purtroppo anche per disegnare politiche pubbliche e progetti di dubbio spessore ed incerta attuazione, come quelli contenuti nel “piano nazionale per le periferie”, varato in Italia nel 2015 sulla base degli studi del cosiddetto G124. La sfida attuale non è cancellare una parola, che può anche non dirci quasi più nulla. Semmai è cercare di capire cosa siano diventate le periferie da più di trent’anni a questa parte. Comprendere come si possa imparare di nuovo a leggerle senza lasciarsi sopraffare dall’assenza di riferimenti e dal disordine imperante; come sia possibile rimetterle al centro di un’azione culturale e politica, per operarvi non solo in vista di interessi locali e parziali. Perché in fondo periferia è, come la cosa che designa, una parola da riqualificare più che da dismettere (o dimenticare). 2.6.16 Peer Review EP (1) “Il resto del mondo”, Limes, 4, 2016, p. 9. Si riferisce ad un recente convegno tenutosi al MIT, del quale si dà conto qui http://www.newgeography.com/content/005208-future-suburbia-report-cambridge (2) Maurizio Cilli, “Periferia: perché non userò più questa parola”, Che fare, 28 aprile 2016 https://www.che-fare.com/parola-periferia/ (3) Francesco Careri, Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Torino, Einaudi, 2006, p. 133. (4) Gaston Bardet, Problèmes d’urbanisme, Paris, Dunod, 1941. (5) Erwin Anton Gutkind, The Twilight of Cities, London, The Free Press of Glencoe, 1962 (cito e traduco dalla edizione francese Le crépuscule des villes, Paris, Stock, 1966, p. 113). |